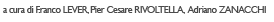Fotogiornalismo
- Testo
- Bibliografia16
- Foto3
- Voci correlate
Autore: Franco Lever
INDICE
1. Storia del f.
1.1. Comunicazione attraverso la fotografia e innovazione tecnica: una stretta relazione 1.2. Il periodo dei giornali illustrati 1.3. Le riviste ‘fotografiche’2. Una distinzione che si sta annullando 3. La fotografia non è più vera della parola 4. Con la fotografia il giornalista non parla un linguaggio universale 5. Problemi irrisolti
Le due parti che compongono la parola f. ne precisano chiaramente il significato: fare informazione (raccogliere, valutare, diffondere notizie) privilegiando come mezzo espressivo la fotografia.
Il termine è nato negli anni Trenta nella forma di fotogiornalista. Così definiva il suo mestiere il berlinese Erich Salomon, specialista nella fotografia di personaggi famosi, che sapeva riprendere in modo irrituale, diretto (le sue immagini venivano definite ‘candide’). Spirito indipendente, caposcuola di un vivace gruppo di giovani fotogiornalisti, dovette fuggire dalla Germania nazista. Riparò in Olanda, ma quando anch’essa venne occupata dai tedeschi fu arrestato e deportato. Morì ad Auschwitz nel 1944.
1.1. Comunicazione attraverso la fotografia e innovazione tecnica: una stretta relazione.
La convinzione che la fotografia fosse il modo più diretto – e dunque più efficace – di documentare i fatti e di farli conoscere al pubblico è un tutt’uno con l’idea di fotografia. La Gazette de France presentava così l’invenzione il 6 gennaio 1839: "Le immagini fotografiche si dipingono da sole dentro la camera oscura e sono impronta durevole degli oggetti". È dunque ovvio che fin dall’inizio si sia fatto ricorso alla fotografia per documentare degli avvenimenti. Gli esempi più antichi a noi pervenuti sono due dagherrotipi: il primo presenta l’incendio della città di Amburgo nel 1842; il secondo, del 1843, riprende il momento della firma del trattato di pace tra Francia e Cina a Whampoa ("una pace di mille anni"!).
Il fotografo era comunque seriamente ostacolato dal peso e dall’ingombro della strumentazione necessaria, come anche dalla macchinosità del procedimento. Quando, ad esempio, nel 1855 il governo inglese inviò il fotografo Roger Fenton in Crimea per documentarvi la guerra, questi, per trasportare l’intera attrezzatura, dovette servirsi di un grande carro coperto, trainato da quattro cavalli. Ogni volta che voleva fare una foto, doveva tirarsi dietro l’intero carro che fungeva anche da laboratorio, perché il materiale sensibile doveva essere preparato, esposto e sviluppato in non più di un quarto d’ora. È evidente che questo modo di procedere aveva delle conseguenze sul risultato del lavoro. Se poi si tiene conto che l’intervento del fotografo era stato sollecitato dalla stessa casa reale per smentire ‘le bugie’ diffuse in patria dai giornali che denunciavano le tremende condizioni in cui vivevano i soldati, si capisce come mai le immagini di Fenton presentino una visione idilliaca della guerra.
Conviene però attirare l’attenzione su due fatti legati al lavoro del primo fotoreporter di guerra che si ricordi (anche se potrà sembrare che si anticipino di qualche decennio fatti e riflessioni).
a) La fotografia non è ancora nata, che già viene usata (in questo caso dai militari e dall’autorità politica) per modificare le informazioni destinate ai cittadini. Proprio perché considerata veridica, la fotografia può essere usata per dire il falso in modo convincente. La fotografia non è mai stata dunque un’autopresentazione della realtà ma sempre un discorso sulla realtà fatto da qualcuno. Nel caso della guerra di Crimea intervennero poi altri fotografi (il francese J. C. Langlois, l’inglese J. Robertson, il veneziano F. Boato) ed essi fecero delle riprese molto diverse da quelle di Fenton.
b) Il pubblico inglese, abituato alle immagini di battaglie dei pittori romantici e degli illustratori dei giornali, al confronto considerò assai noiose le fotografie di Fenton. Lo stesso Times ebbe a commentare: "Il fotografo che segue gli eserciti moderni non può far altro che registrare situazioni di riposo e quell’atmosfera di natura morta che succede alla battaglia" (Newhall, 1984). Il ritardo con cui la fotografia ha conquistato un proprio spazio sui giornali è dovuto anche all’ immaginario di una determinata epoca: la gente (come anche i direttori di giornale) hanno dovuto familiarizzarsi con la fotografia prima di adottarla come strumento normale di comunicazione.
Negli anni successivi le condizioni di lavoro del fotografo cambiarono velocemente e di pari passo i risultati. Si può ripercorrere lo sviluppo tecnico della strumentazione fotografica constatando come i fotografi interessati a documentare gli avvenimenti siano sempre stati i primi a impossessarsi delle novità tecniche, quando non furono essi stessi gli autori o gli ispiratori di cambi e innovazioni. Questo vale anzitutto per la macchina fotografica come tale: ottiche più luminose, otturatori più veloci e precisi, materiali più sensibili, corpi macchina più piccoli, sistemi di illuminazione sicuri e controllabili, integrazione di tutte le componenti in un unico sistema a controllo digitale. Si può così notare uno sviluppo parallelo: con la maggior duttilità dello strumento cambia il tipo di fotografia, sempre meno in posa, meno teatrale, meno costruita, sempre più rubata allo stesso avvenimento; cambia anche il tipo di avvenimento che viene documentato, perché una porzione sempre maggiore di realtà è oggetto di ripresa da parte del fotografo, dal momento che il movimento del soggetto da riprendere, la scarsa luce ambientale, la precarietà della situazione, i controlli non pongono più problemi tecnici insormontabili.
Hanno contribuito al cambiamento anche lo sviluppo dei mezzi di trasporto, i sistemi di comunicazione in genere e, in particolare, i sistemi di trasmissione e distribuzione delle immagini. Per quasi cinquant’anni è lo stesso fotografo che propone ai giornali le sue fotografie. Solo dopo il 1890 nascono le prime agenzie fotografiche con la funzione di archivio e di tramite commerciale tra fotografo e giornali. Nel 1907 E. Belin mise a punto il belinografo, lo strumento che trasmetteva le immagini per mezzo del telegrafo; a partire dal 1921 la stessa cosa si poté fare via radio.
Durante la seconda guerra mondiale molti fotografi spedivano nelle retrovie i negativi appena impressionati, affidando quindi ad altri lo sviluppo in modo da accelerare l’arrivo delle immagini alle agenzie e/o ai giornali. Non senza rischi. Ad esempio il grande fotoreporter Robert Capa – pseudonimo di André Friedman – partecipò allo sbarco alleato in Normandia il 6 giugno 1944 e scattò foto su foto, ma di quelle immagini sono rimaste sulla pellicola solo delle ombre evanescenti a causa di un grave errore del tecnico di laboratorio a cui erano stati affidati i negativi. Oggi il fotografo, in qualsiasi punto del globo si trovi, può collegare la sua macchina digitale a un telefono (normale, cellulare o satellitare) e qualche istante dopo l’immagine è sullo schermo del computer dell’agenzia o del quotidiano per cui lavora.
La progressiva riduzione delle difficoltà tecniche di ripresa e di trasmissione ha dato al fotografo-giornalista maggiori chance di cogliere la notizia nella sua immediatezza, per esprimerla in singole immagini o in un racconto per immagini.
1.2. Il periodo dei giornali illustrati.
La fotografia è stata utilizzata per documentare gli avvenimenti di vario tipo e comunque per raccogliere notizie sulla vita sociale molto prima che i giornali fossero in grado di utilizzarla direttamente o anche fossero disposti ad accoglierla. Il giornale è nato come strumento della parola scritta; l’immagine vi compariva solo raramente, sia perché l’eventuale disegno non portava con sé una particolare carica di verità o di attualità, sia perché il processo che consentiva la stampa dell’immagine non aveva i tempi rapidi della scrittura e della composizione della pagina per mezzo dei caratteri mobili. Per stampare un’immagine ci si serviva della xilografia: l’immagine – rovesciata destra/sinistra – doveva essere incisa da uno specialista su una tavoletta di legno, in modo che le superfici o le righe da riprodurre nere risultassero in rilievo e quelle bianche corrispondessero a parti asportate dallo scalpello. In questo modo la matrice, di spessore e dimensione prestabiliti, poteva essere facilmente ‘impaginata’ insieme agli altri blocchi di testo scritto, per formare la pagina intera. Il rullo inchiostratore lasciava un velo di inchiostro su tutte le parti in rilievo, fossero caratteri o parti di una immagine, e così sulla pagina finale risultavano stampati con uno stesso procedimento sia il testo che le immagini.
La fotografia attirò immediatamente l’attenzione dei direttori dei giornali, ma non c’era modo di includerla direttamente nel processo di stampa, si doveva comunque passare attraverso la sua riproduzione xilografica. Quest’operazione esigeva personale specializzato; occorrevano poi dalle tre alle quattro settimane prima che il cliché fosse pronto, il che annullava gran parte della efficacia informativa dell’immagine. Molto più rapido, economico ed efficace il lavoro di un illustratore, il quale poteva trovare spunto e ispirazione dalle eventuali fotografie.
Solo attorno al 1880 venne messa a punto la tecnica della ‘lastra a mezzatinta’ che consentiva direttamente l’uso tipografico della fotografia (il merito va soprattutto a Frederic E. Ives in USA e a Georg Meisenbach in Germania). Nella fase di riproduzione si poneva sul negativo un retino finissimo che trasformava la continuità dell’immagine fotografica in un mosaico di punti, di varia grandezza a seconda dell’intensità dell’originale; la lastra, rivestita di una gelatina particolare, una volta esposta, veniva trattata con acido capace di incidere il materiale in modo differenziato, cosicché i singoli puntini rimanevano in rilievo. La lastra risultava allora perfettamente stampabile.
Passarono però ancora vari decenni prima che la xilografia fosse abbandonata. Due le ragioni: una di tipo comunicativo, l’altra economica. Il linguaggio dei disegnatori aveva abituato pubblico e direttori a uno stile ampolloso, a effetto, non riscontrabile nella fotografia, che è meno affabulatrice di quanto possa essere un disegno. Esempi di questo tipo di illustrazione si potevano trovare nel settimanale italiano La Domenica del Corriere, la cui copertina era sempre una tavola illustrata; oppure si veda oggi la pagina del settimanale Famiglia Cristiana, dove alcuni fatti di attualità vengono presentati nel modo ‘spettacolare’ proprio dei giornali illustrati di un tempo. L’altra ragione era di tipo economico: adottare il processo fotografico significava smantellare un pezzo della catena produttiva (strumenti e personale) per sostituirla con un’altra.
Nonostante il fatto che mancasse loro la committenza – e dunque il finanziamento – dei giornali, molti fotografi interpretarono il loro lavoro con lo spirito del giornalista fotografo: guardare con occhio attento e critico a quanto accade nella realtà, per fare memoria, per fare conoscere i fatti, per promuovere il cambiamento, quando la situazione si rivelasse inaccettabile. I settori più frequentemente documentati dai fotografi nella seconda parte dell’Ottocento sono state le innumerevoli guerre (dopo quella di Crimea, quelle nelle colonie, in Messico, negli Stati Uniti, in Europa...), ma anche la realizzazione di grandi opere civili (ad esempio la costruzione della ferrovia transcontinentale in USA documentata da A. Gardner), la situazione di sofferenza e di ingiustizia in cui viveva grande parte della popolazione (fortemente innovativa l’opera di Jakob A. Riis negli anni 1880 sulla vita della gente nei bassi fondi di New York). Con grande interesse oggi si guarda al lavoro di alcuni fotografi che – senza alcun ritorno economico – hanno dedicato tanta parte del loro lavoro alla documentazione della vita quotidiana della loro città e della loro nazione: per citarne alcuni, J. E. Atget per Parigi, G. Primoli per l’Italia, B. Stone per l’Inghilterra, E. S. Curtis per le popolazioni indiane del Nord America.
1.3. Le riviste ‘fotografiche’.
Il 15 marzo del 1884 l’Illustrierte Zeitung (il Giornale illustrato) di Lipsia pubblicava due fotografie utilizzando il processo della lastra incisa a mezzatinta. Il direttore commentava l’avvenimento in questo modo: "Per la prima volta vediamo due fotografie istantanee stampate contemporaneamente al testo... La fotografia ha aperto nuove strade. Ora il suo motto è, per ogni rispetto, ‘velocità’: velocità nel cogliere l’immagine, velocità nel riprodurla". Né il pubblico né gli editori però erano ancora pronti – come si è detto – ad accogliere la fotografia come linguaggio normale delle notizie: la parola e l’illustrazione continuarono a occupare la massima parte dello spazio (può essere interessante ricordare, a questo proposito, che il Times di Londra e Le Monde di Parigi hanno pubblicato le loro prime fotografie negli anni Ottanta).
Dopo il 1890 comparvero un po’ dovunque delle riviste interessate a dare spazio alla fotografia. Ma è a partire dal 1920 che si affermano le riviste fotografiche e insieme un nuovo stile di fare giornalismo, dove l’immagine non viene utilizzata soltanto per illustrare o abbellire una pagina o un articolo. All’inizio del secolo l’esempio l’avevano dato gli americani, ma poi è soprattutto in Germania che fiorisce questo genere giornalistico: i servizi sono pensati fin dall’inizio come racconto fotografico, il testo gioca in dialogo con le immagini e il tutto è frutto di una intensa collaborazione tra redazione e fotografo. La ragione del primato della Germania è motivata da un duplice fatto: in quel momento il Paese è un vero crogiolo di idee, sono presenti forti tensioni sociali e insieme vari movimenti artistici innovatori; è inoltre il Paese più avanzato dal punto di vista tecnologico, sia per quanto riguarda la tecnica di stampa (oltre all’immagine ora anche il testo è riprodotto sulla lastra della rotativa), sia per la chimica (messa a punto di pellicole e carte fotografiche), sia per l’ottica e la meccanica: le macchine fotografiche più adatte al f. sono tedesche: la Ermanox e la Leica, ambedue commercializzate negli anni Venti (Macchina fotografica).
Con l’avvento del nazismo nel 1933 il clima culturale in Germania cambia completamente; non c’è più né spazio per la ricerca culturale, né tanto meno libertà di pensiero. Molti tra gli editori, i giornalisti e i fotografi vengono eliminati; solo i più fortunati riescono a emigrare, chi verso l’Est, chi verso l’Ovest, a seconda dell’ideologia o della speranza che li anima.
Sono gli USA che, insieme a molti di questi uomini, accolgono le proposte e i progetti che essi portano con sé, realizzandoli in grande stile. Due riviste, nate quasi contemporaneamente, diventano l’emblema di questo modo di concepire il giornalismo: Life (primo numero 23 novembre 1936) e Look (primo numero: gennaio 1937). Nell’annunciare il progetto di Life Henry Luce dichiarava (1934): "Vedere la vita, vedere il mondo, essere testimoni oculari dei grandi avvenimenti; scrutare i visi dei poveri e gli atteggiamenti dei superbi; (...) vedere cose lontane migliaia di chilometri, cose nascoste dietro i muri, cose pericolose da avvicinare; vedere le donne che gli uomini amano e molti bambini; vedere e provare gioia; vedere e stupire; vedere ed essere arricchiti..." Il modello di settimanale ebbe un enorme successo e venne copiato in tutto il mondo. In Italia furono soprattutto Epoca ed Europeo che coltivarono questo tipo di giornalismo.
La crisi sopravvenne nel momento di massima espansione: nel 1972 Life aveva una tiratura di 8 milioni di copie settimanali (40 milioni di lettori), eppure negli ultimi anni perdeva migliaia di dollari. Con l’ultimo numero di quell’anno Life cessò le pubblicazioni (Look aveva preso la stessa decisione l’anno precedente). La fine dell’epoca d’oro del f. fu determinata dal successo della televisione, un medium direttamente concorrenziale sia come prodotto (il programma espresso da Luce nel 1934 di fatto venne assunto dalla televisione che aveva il vantaggio della tempestività e dell’intrusività: arrivava ogni giorno, in ogni casa), sia come pubblico (di fatto il medesimo). C’è anche un’altra ragione che ha accelerato il crollo delle riviste fotografiche: era cambiato il modo di organizzare il lavoro dei giornalisti e dei fotografi, non era più sostenibile che una singola rivista avesse come suoi dipendenti centinaia di fotografi. Le agenzie e i fotografi freelance (che operano in proprio) avevano ormai una efficacia e una duttilità irraggiungibili. Meglio chiudere che fallire rovinosamente. Tutte le riviste che avevano adottato il progetto Life seguirono lo stesso destino.
In prospettiva, però, l’insieme della professione è destinato a cambiare. I confini tra le varie tecniche comunicative si stanno assottigliando grazie alla tecnologia che è in grado di affidare alle macchine molti compiti ieri risolvibili solo da un professionista specifico. Per realizzare una fotografia valida, per fare una buona ripresa televisiva, per registrare un’intervista ascoltabile occorre un minimo di apprendimento, il resto lo sa eseguire la macchina. Il risultato poi, in tutti e tre i casi, è un file di tipo digitale, che si lascia elaborare – a un primo livello – con facilità; anche lo strumento per preparare il proprio pezzo e per inviarlo all’agenzia o alla redazione è lo stesso, il computer collegato al telefono, tradizionale, cellulare o satellitare che sia.
Le stesse agenzie, le stesse redazioni non possono più limitarsi a trattare soltanto testo o soltanto immagini o soltanto contributi radiofonici. Il giornale, la radio, la televisione non sono più mondi tra loro separati. Il prodotto è un unico, la notizia (comunque espressa), e dunque le aziende si strutturano in modo unitario (come società multimediali) e chiedono che il giornalista sappia esprimersi in tutte le diverse forme.
Per il giornalista questo comunque non costituisce la maggiore difficoltà, che resta la capacità di cogliere in anticipo la notizia, di sapere selezionare e interpretare i fatti, riducendo al minimo la propria dipendenza da una ideologia (il che avviene quando non se ne nasconde l’esistenza).
Può essere utile un paragone: se il cacciatore venisse a sapere che la volpe ha imparato a lasciare sulla neve non le sue tracce, ma quelle di un lupo, non continuerebbe a fidarsi delle impronte che vede, ma si preoccuperebbe di scoprire in che modo la volpe lavori per nascondere il suo passaggio, così da smascherare la bugia. L’oggettività non è frutto automatico della fotografia; è nell’intenzione e nella corrispondente azione dell’emittente e dunque è il ‘lettore’ che deve saper formulare una sua valutazione davanti a ogni messaggio, sia esso un testo orale o scritto o una fotografia. (Immagine. A. Introduzione)
Non ha dunque senso affermare che esiste un unico codice fotografico, conosciuto il quale tutti possono leggere tutte le fotografie. Se conosco il codice usato dal fotografo potrò leggere quale intervento ha fatto, ma non ho la garanzia di comprendere ciascuno degli elementi da lui utilizzati. Ad esempio, quando viene fatto il ritratto di una persona, entrano in gioco messaggi di tipo prossemico (Prossemica), messaggi legati alla gestualità (ciò che dicono il volto, gli occhi, la bocca, il trucco, le mani, la positura del corpo), messaggi espressi dall’ abbigliamento, dall’ambiente e dal suo arredamento. Il risultato finale – la fotografia – è sotto gli occhi di tutti, ma non è possibile affermare che tutti la leggano alla stessa maniera. È vero che la diffusione nel mondo della televisione e delle lingue occidentali (che si scrivono in modo equivalente e dunque organizzano lo spazio bidimensionale in modo simile) ha dato vita a una specie di esperanto grafico-visivo, ma non è vero che l’espressione di un viso napoletano sia trasparente per un giapponese o un lituano (e – ovviamente – viceversa).
Meglio affermare che la fotografia dice molte cose e, in quel che dice, è polisemica, si presta cioè amolte letture. Per completarla e per ridurne l’ambiguità molto spesso c’è bisogno dell’intervento di un testo capace di vincolare la libertà del lettore e dirigerlo sul messaggio inteso dall’emittente. Se la fotografia non dice, o non dice a tutti, il dove, il chi, il che cosa, il come, il quando, il perché, lo scopo di un determinato avvenimento, è giocoforza ricorrere ad altri testi: possono essere anche altre fotografie ma spesso il testo scritto – nelle varie lingue! – si rivela indispensabile.
Non è logico dunque contrapporre la parola scritta all’immagine sulla base della maggiore veridicità e comprensibilità dell’una rispetto all’altra. Così non ha più senso contrapporre la figura del giornalista a quella del fotogiornalista (o del giornalista che lavora alla radio, in televisione, in Internet). Oggi la stessa persona può, e probabilmente deve, sapersi esprimere con tutti questi media.
– L’informazione opposta allo spettacolo. Sono realtà diverse, ma non si escludono in modo radicale. L’errore è confonderle, fingendo di fare informazione là dove invece interessa soltanto catturare l’attenzione del pubblico per scopi diversi che fornire notizie.
– Il diritto/dovere di informare, contrapposto al bene del singolo e al bene comune. Ci sono dei limiti da rispettare (come nel caso della privacy), ma ci sono anche limiti che andrebbero violati, ad esempio molti dei divieti imposti da una dittatura.
– Il rischio che l’informazione diventi condanna. In alcuni casi la scelta – se scattare o non scattare una fotografia – può essere tragica (comunque si decida). Nel 1989, a Pechino, nella piazza Tien An Men, sarebbe stato un delitto non documentare al mondo la rivolta degli studenti, ma è bene ricordare che la scelta di documentare con la fotografia l’accaduto ha dato in mano alla polizia lo strumento per identificare le persone da fucilare.
– Le immagine sono efficaci, ma non da sole: è senz’altro vero che il sacrificio di molti fotografi e cameraman morti in Vietnam (come in altri conflitti), provocando con le loro immagini l’orrore della guerra e un vivo senso di ribellione nella maggioranza di cittadini, ha contribuito ad accelerare la conclusione del conflitto (la controprova la si ha osservando il modo di operare dei militari nei conflitti successivi: hanno cercato in tutti i modi di gestire a modo loro le immagini e i flussi informativi). Non sempre però le cose funzionano alla stessa maniera: è da un secolo che le immagini del sottosviluppo e della fame sono sotto gli occhi di tutti, ma gli ingiusti squilibri non si sono attenuati.
Tutte queste opposizioni sono oggetto di studio e molta letteratura è disponibile al riguardo. Si è arrivati anche alla formulazione di proposte operative concrete da parte di vari codici deontologici nella forma di autoregolazione o nella forma di veri e proprie leggi.
Il termine è nato negli anni Trenta nella forma di fotogiornalista. Così definiva il suo mestiere il berlinese Erich Salomon, specialista nella fotografia di personaggi famosi, che sapeva riprendere in modo irrituale, diretto (le sue immagini venivano definite ‘candide’). Spirito indipendente, caposcuola di un vivace gruppo di giovani fotogiornalisti, dovette fuggire dalla Germania nazista. Riparò in Olanda, ma quando anch’essa venne occupata dai tedeschi fu arrestato e deportato. Morì ad Auschwitz nel 1944.
1. Storia del f.
Il termine f. può essere inteso in modo specifico e allora ci si dovrebbe limitare a descrivere un modo di fare giornalismo nato negli anni Trenta (Sontag 1976). Se invece, si assume con l’ampio significato che sottende (mettere la fotografia a servizio della notizia), è l’intera storia della fotografia che può essere riletta da un punto di vista originale. È quanto suggeriamo di fare.1.1. Comunicazione attraverso la fotografia e innovazione tecnica: una stretta relazione.
La convinzione che la fotografia fosse il modo più diretto – e dunque più efficace – di documentare i fatti e di farli conoscere al pubblico è un tutt’uno con l’idea di fotografia. La Gazette de France presentava così l’invenzione il 6 gennaio 1839: "Le immagini fotografiche si dipingono da sole dentro la camera oscura e sono impronta durevole degli oggetti". È dunque ovvio che fin dall’inizio si sia fatto ricorso alla fotografia per documentare degli avvenimenti. Gli esempi più antichi a noi pervenuti sono due dagherrotipi: il primo presenta l’incendio della città di Amburgo nel 1842; il secondo, del 1843, riprende il momento della firma del trattato di pace tra Francia e Cina a Whampoa ("una pace di mille anni"!).
Il fotografo era comunque seriamente ostacolato dal peso e dall’ingombro della strumentazione necessaria, come anche dalla macchinosità del procedimento. Quando, ad esempio, nel 1855 il governo inglese inviò il fotografo Roger Fenton in Crimea per documentarvi la guerra, questi, per trasportare l’intera attrezzatura, dovette servirsi di un grande carro coperto, trainato da quattro cavalli. Ogni volta che voleva fare una foto, doveva tirarsi dietro l’intero carro che fungeva anche da laboratorio, perché il materiale sensibile doveva essere preparato, esposto e sviluppato in non più di un quarto d’ora. È evidente che questo modo di procedere aveva delle conseguenze sul risultato del lavoro. Se poi si tiene conto che l’intervento del fotografo era stato sollecitato dalla stessa casa reale per smentire ‘le bugie’ diffuse in patria dai giornali che denunciavano le tremende condizioni in cui vivevano i soldati, si capisce come mai le immagini di Fenton presentino una visione idilliaca della guerra.
Conviene però attirare l’attenzione su due fatti legati al lavoro del primo fotoreporter di guerra che si ricordi (anche se potrà sembrare che si anticipino di qualche decennio fatti e riflessioni).
a) La fotografia non è ancora nata, che già viene usata (in questo caso dai militari e dall’autorità politica) per modificare le informazioni destinate ai cittadini. Proprio perché considerata veridica, la fotografia può essere usata per dire il falso in modo convincente. La fotografia non è mai stata dunque un’autopresentazione della realtà ma sempre un discorso sulla realtà fatto da qualcuno. Nel caso della guerra di Crimea intervennero poi altri fotografi (il francese J. C. Langlois, l’inglese J. Robertson, il veneziano F. Boato) ed essi fecero delle riprese molto diverse da quelle di Fenton.
b) Il pubblico inglese, abituato alle immagini di battaglie dei pittori romantici e degli illustratori dei giornali, al confronto considerò assai noiose le fotografie di Fenton. Lo stesso Times ebbe a commentare: "Il fotografo che segue gli eserciti moderni non può far altro che registrare situazioni di riposo e quell’atmosfera di natura morta che succede alla battaglia" (Newhall, 1984). Il ritardo con cui la fotografia ha conquistato un proprio spazio sui giornali è dovuto anche all’ immaginario di una determinata epoca: la gente (come anche i direttori di giornale) hanno dovuto familiarizzarsi con la fotografia prima di adottarla come strumento normale di comunicazione.
Negli anni successivi le condizioni di lavoro del fotografo cambiarono velocemente e di pari passo i risultati. Si può ripercorrere lo sviluppo tecnico della strumentazione fotografica constatando come i fotografi interessati a documentare gli avvenimenti siano sempre stati i primi a impossessarsi delle novità tecniche, quando non furono essi stessi gli autori o gli ispiratori di cambi e innovazioni. Questo vale anzitutto per la macchina fotografica come tale: ottiche più luminose, otturatori più veloci e precisi, materiali più sensibili, corpi macchina più piccoli, sistemi di illuminazione sicuri e controllabili, integrazione di tutte le componenti in un unico sistema a controllo digitale. Si può così notare uno sviluppo parallelo: con la maggior duttilità dello strumento cambia il tipo di fotografia, sempre meno in posa, meno teatrale, meno costruita, sempre più rubata allo stesso avvenimento; cambia anche il tipo di avvenimento che viene documentato, perché una porzione sempre maggiore di realtà è oggetto di ripresa da parte del fotografo, dal momento che il movimento del soggetto da riprendere, la scarsa luce ambientale, la precarietà della situazione, i controlli non pongono più problemi tecnici insormontabili.
Hanno contribuito al cambiamento anche lo sviluppo dei mezzi di trasporto, i sistemi di comunicazione in genere e, in particolare, i sistemi di trasmissione e distribuzione delle immagini. Per quasi cinquant’anni è lo stesso fotografo che propone ai giornali le sue fotografie. Solo dopo il 1890 nascono le prime agenzie fotografiche con la funzione di archivio e di tramite commerciale tra fotografo e giornali. Nel 1907 E. Belin mise a punto il belinografo, lo strumento che trasmetteva le immagini per mezzo del telegrafo; a partire dal 1921 la stessa cosa si poté fare via radio.
Durante la seconda guerra mondiale molti fotografi spedivano nelle retrovie i negativi appena impressionati, affidando quindi ad altri lo sviluppo in modo da accelerare l’arrivo delle immagini alle agenzie e/o ai giornali. Non senza rischi. Ad esempio il grande fotoreporter Robert Capa – pseudonimo di André Friedman – partecipò allo sbarco alleato in Normandia il 6 giugno 1944 e scattò foto su foto, ma di quelle immagini sono rimaste sulla pellicola solo delle ombre evanescenti a causa di un grave errore del tecnico di laboratorio a cui erano stati affidati i negativi. Oggi il fotografo, in qualsiasi punto del globo si trovi, può collegare la sua macchina digitale a un telefono (normale, cellulare o satellitare) e qualche istante dopo l’immagine è sullo schermo del computer dell’agenzia o del quotidiano per cui lavora.
La progressiva riduzione delle difficoltà tecniche di ripresa e di trasmissione ha dato al fotografo-giornalista maggiori chance di cogliere la notizia nella sua immediatezza, per esprimerla in singole immagini o in un racconto per immagini.
1.2. Il periodo dei giornali illustrati.
La fotografia è stata utilizzata per documentare gli avvenimenti di vario tipo e comunque per raccogliere notizie sulla vita sociale molto prima che i giornali fossero in grado di utilizzarla direttamente o anche fossero disposti ad accoglierla. Il giornale è nato come strumento della parola scritta; l’immagine vi compariva solo raramente, sia perché l’eventuale disegno non portava con sé una particolare carica di verità o di attualità, sia perché il processo che consentiva la stampa dell’immagine non aveva i tempi rapidi della scrittura e della composizione della pagina per mezzo dei caratteri mobili. Per stampare un’immagine ci si serviva della xilografia: l’immagine – rovesciata destra/sinistra – doveva essere incisa da uno specialista su una tavoletta di legno, in modo che le superfici o le righe da riprodurre nere risultassero in rilievo e quelle bianche corrispondessero a parti asportate dallo scalpello. In questo modo la matrice, di spessore e dimensione prestabiliti, poteva essere facilmente ‘impaginata’ insieme agli altri blocchi di testo scritto, per formare la pagina intera. Il rullo inchiostratore lasciava un velo di inchiostro su tutte le parti in rilievo, fossero caratteri o parti di una immagine, e così sulla pagina finale risultavano stampati con uno stesso procedimento sia il testo che le immagini.
La fotografia attirò immediatamente l’attenzione dei direttori dei giornali, ma non c’era modo di includerla direttamente nel processo di stampa, si doveva comunque passare attraverso la sua riproduzione xilografica. Quest’operazione esigeva personale specializzato; occorrevano poi dalle tre alle quattro settimane prima che il cliché fosse pronto, il che annullava gran parte della efficacia informativa dell’immagine. Molto più rapido, economico ed efficace il lavoro di un illustratore, il quale poteva trovare spunto e ispirazione dalle eventuali fotografie.
Solo attorno al 1880 venne messa a punto la tecnica della ‘lastra a mezzatinta’ che consentiva direttamente l’uso tipografico della fotografia (il merito va soprattutto a Frederic E. Ives in USA e a Georg Meisenbach in Germania). Nella fase di riproduzione si poneva sul negativo un retino finissimo che trasformava la continuità dell’immagine fotografica in un mosaico di punti, di varia grandezza a seconda dell’intensità dell’originale; la lastra, rivestita di una gelatina particolare, una volta esposta, veniva trattata con acido capace di incidere il materiale in modo differenziato, cosicché i singoli puntini rimanevano in rilievo. La lastra risultava allora perfettamente stampabile.
Passarono però ancora vari decenni prima che la xilografia fosse abbandonata. Due le ragioni: una di tipo comunicativo, l’altra economica. Il linguaggio dei disegnatori aveva abituato pubblico e direttori a uno stile ampolloso, a effetto, non riscontrabile nella fotografia, che è meno affabulatrice di quanto possa essere un disegno. Esempi di questo tipo di illustrazione si potevano trovare nel settimanale italiano La Domenica del Corriere, la cui copertina era sempre una tavola illustrata; oppure si veda oggi la pagina del settimanale Famiglia Cristiana, dove alcuni fatti di attualità vengono presentati nel modo ‘spettacolare’ proprio dei giornali illustrati di un tempo. L’altra ragione era di tipo economico: adottare il processo fotografico significava smantellare un pezzo della catena produttiva (strumenti e personale) per sostituirla con un’altra.
Nonostante il fatto che mancasse loro la committenza – e dunque il finanziamento – dei giornali, molti fotografi interpretarono il loro lavoro con lo spirito del giornalista fotografo: guardare con occhio attento e critico a quanto accade nella realtà, per fare memoria, per fare conoscere i fatti, per promuovere il cambiamento, quando la situazione si rivelasse inaccettabile. I settori più frequentemente documentati dai fotografi nella seconda parte dell’Ottocento sono state le innumerevoli guerre (dopo quella di Crimea, quelle nelle colonie, in Messico, negli Stati Uniti, in Europa...), ma anche la realizzazione di grandi opere civili (ad esempio la costruzione della ferrovia transcontinentale in USA documentata da A. Gardner), la situazione di sofferenza e di ingiustizia in cui viveva grande parte della popolazione (fortemente innovativa l’opera di Jakob A. Riis negli anni 1880 sulla vita della gente nei bassi fondi di New York). Con grande interesse oggi si guarda al lavoro di alcuni fotografi che – senza alcun ritorno economico – hanno dedicato tanta parte del loro lavoro alla documentazione della vita quotidiana della loro città e della loro nazione: per citarne alcuni, J. E. Atget per Parigi, G. Primoli per l’Italia, B. Stone per l’Inghilterra, E. S. Curtis per le popolazioni indiane del Nord America.
1.3. Le riviste ‘fotografiche’.
Il 15 marzo del 1884 l’Illustrierte Zeitung (il Giornale illustrato) di Lipsia pubblicava due fotografie utilizzando il processo della lastra incisa a mezzatinta. Il direttore commentava l’avvenimento in questo modo: "Per la prima volta vediamo due fotografie istantanee stampate contemporaneamente al testo... La fotografia ha aperto nuove strade. Ora il suo motto è, per ogni rispetto, ‘velocità’: velocità nel cogliere l’immagine, velocità nel riprodurla". Né il pubblico né gli editori però erano ancora pronti – come si è detto – ad accogliere la fotografia come linguaggio normale delle notizie: la parola e l’illustrazione continuarono a occupare la massima parte dello spazio (può essere interessante ricordare, a questo proposito, che il Times di Londra e Le Monde di Parigi hanno pubblicato le loro prime fotografie negli anni Ottanta).
Dopo il 1890 comparvero un po’ dovunque delle riviste interessate a dare spazio alla fotografia. Ma è a partire dal 1920 che si affermano le riviste fotografiche e insieme un nuovo stile di fare giornalismo, dove l’immagine non viene utilizzata soltanto per illustrare o abbellire una pagina o un articolo. All’inizio del secolo l’esempio l’avevano dato gli americani, ma poi è soprattutto in Germania che fiorisce questo genere giornalistico: i servizi sono pensati fin dall’inizio come racconto fotografico, il testo gioca in dialogo con le immagini e il tutto è frutto di una intensa collaborazione tra redazione e fotografo. La ragione del primato della Germania è motivata da un duplice fatto: in quel momento il Paese è un vero crogiolo di idee, sono presenti forti tensioni sociali e insieme vari movimenti artistici innovatori; è inoltre il Paese più avanzato dal punto di vista tecnologico, sia per quanto riguarda la tecnica di stampa (oltre all’immagine ora anche il testo è riprodotto sulla lastra della rotativa), sia per la chimica (messa a punto di pellicole e carte fotografiche), sia per l’ottica e la meccanica: le macchine fotografiche più adatte al f. sono tedesche: la Ermanox e la Leica, ambedue commercializzate negli anni Venti (Macchina fotografica).
Con l’avvento del nazismo nel 1933 il clima culturale in Germania cambia completamente; non c’è più né spazio per la ricerca culturale, né tanto meno libertà di pensiero. Molti tra gli editori, i giornalisti e i fotografi vengono eliminati; solo i più fortunati riescono a emigrare, chi verso l’Est, chi verso l’Ovest, a seconda dell’ideologia o della speranza che li anima.
Sono gli USA che, insieme a molti di questi uomini, accolgono le proposte e i progetti che essi portano con sé, realizzandoli in grande stile. Due riviste, nate quasi contemporaneamente, diventano l’emblema di questo modo di concepire il giornalismo: Life (primo numero 23 novembre 1936) e Look (primo numero: gennaio 1937). Nell’annunciare il progetto di Life Henry Luce dichiarava (1934): "Vedere la vita, vedere il mondo, essere testimoni oculari dei grandi avvenimenti; scrutare i visi dei poveri e gli atteggiamenti dei superbi; (...) vedere cose lontane migliaia di chilometri, cose nascoste dietro i muri, cose pericolose da avvicinare; vedere le donne che gli uomini amano e molti bambini; vedere e provare gioia; vedere e stupire; vedere ed essere arricchiti..." Il modello di settimanale ebbe un enorme successo e venne copiato in tutto il mondo. In Italia furono soprattutto Epoca ed Europeo che coltivarono questo tipo di giornalismo.
La crisi sopravvenne nel momento di massima espansione: nel 1972 Life aveva una tiratura di 8 milioni di copie settimanali (40 milioni di lettori), eppure negli ultimi anni perdeva migliaia di dollari. Con l’ultimo numero di quell’anno Life cessò le pubblicazioni (Look aveva preso la stessa decisione l’anno precedente). La fine dell’epoca d’oro del f. fu determinata dal successo della televisione, un medium direttamente concorrenziale sia come prodotto (il programma espresso da Luce nel 1934 di fatto venne assunto dalla televisione che aveva il vantaggio della tempestività e dell’intrusività: arrivava ogni giorno, in ogni casa), sia come pubblico (di fatto il medesimo). C’è anche un’altra ragione che ha accelerato il crollo delle riviste fotografiche: era cambiato il modo di organizzare il lavoro dei giornalisti e dei fotografi, non era più sostenibile che una singola rivista avesse come suoi dipendenti centinaia di fotografi. Le agenzie e i fotografi freelance (che operano in proprio) avevano ormai una efficacia e una duttilità irraggiungibili. Meglio chiudere che fallire rovinosamente. Tutte le riviste che avevano adottato il progetto Life seguirono lo stesso destino.
2. Una distinzione che si sta annullando
Tra le due professioni – giornalista e fotogiornalista – è quella del giornalista che in passato ha occupato il ruolo più eminente; e la supremazia che nei giornali il testo aveva e ha sull’immagine si riscontra anche oggi nella carriera delle persone. Le cose non sono ancora cambiate (in Italia ad esempio il fotoreporter non ha pieno riconoscimento come fotogiornalista), ma è indubbio che la professione sta modificandosi in modo radicale. Il giornalista dell’immagine (fotografo o telereporter) continua a essere là dove avvengono i fatti più drammatici, coinvolgenti e dunque interessanti per il pubblico, sempre testimone diretto delle notizie che dà, mentre il giornalista della parola – salvo eccezioni, che però tendono a diminuire – è bloccato davanti a una tastiera con il compito di riscrivere i take che le agenzie fanno arrivare sul terminale o per tradurre quanto il servizio televisivo della CNN o della BBC World gli stanno trasmettendo sul monitor. Perché la pagina di cronaca o il commento possono essere fatti a tavolino, la fotografia o il reportage televisivo no, bisogna essere sul posto.In prospettiva, però, l’insieme della professione è destinato a cambiare. I confini tra le varie tecniche comunicative si stanno assottigliando grazie alla tecnologia che è in grado di affidare alle macchine molti compiti ieri risolvibili solo da un professionista specifico. Per realizzare una fotografia valida, per fare una buona ripresa televisiva, per registrare un’intervista ascoltabile occorre un minimo di apprendimento, il resto lo sa eseguire la macchina. Il risultato poi, in tutti e tre i casi, è un file di tipo digitale, che si lascia elaborare – a un primo livello – con facilità; anche lo strumento per preparare il proprio pezzo e per inviarlo all’agenzia o alla redazione è lo stesso, il computer collegato al telefono, tradizionale, cellulare o satellitare che sia.
Le stesse agenzie, le stesse redazioni non possono più limitarsi a trattare soltanto testo o soltanto immagini o soltanto contributi radiofonici. Il giornale, la radio, la televisione non sono più mondi tra loro separati. Il prodotto è un unico, la notizia (comunque espressa), e dunque le aziende si strutturano in modo unitario (come società multimediali) e chiedono che il giornalista sappia esprimersi in tutte le diverse forme.
Per il giornalista questo comunque non costituisce la maggiore difficoltà, che resta la capacità di cogliere in anticipo la notizia, di sapere selezionare e interpretare i fatti, riducendo al minimo la propria dipendenza da una ideologia (il che avviene quando non se ne nasconde l’esistenza).
3. La fotografia non è più vera della parola
Si può parlare di una superiorità della fotografia rispetto al testo scritto? La tesi è sostenuta spesso con vari argomenti, primi tra tutti quello dell’oggettività della fotografia e quello dell’universalità del suo linguaggio. Ambedue gli argomenti sono espressione di una notevole ingenuità. Pur concedendo alla fotografia di essere ‘orma chimica della luce riflessa da oggetti reali’, non si può ignorare che il processo di produzione di quest’orma è modificabile in così tanti modi da parte del fotografo, che il risultato risulta essere più frutto della sua intenzione che non dei raggi di luce penetrati dentro l’obiettivo. Il fotografo di fatto elabora un suo ‘testo’ e usa il processo fotografico per ‘scriverlo’, esprimendo così una sua impressione e un suo giudizio su quanto vede; come tutti gli altri ‘comunicatori’ può utilizzare i dati oggettivi o può ignorarli e sovrapporvi il proprio sistema di attese (affermando il falso, magari soltanto con la rinuncia a fare la ripresa, quando ciò che vede non corrisponde a quanto vuol dire).Può essere utile un paragone: se il cacciatore venisse a sapere che la volpe ha imparato a lasciare sulla neve non le sue tracce, ma quelle di un lupo, non continuerebbe a fidarsi delle impronte che vede, ma si preoccuperebbe di scoprire in che modo la volpe lavori per nascondere il suo passaggio, così da smascherare la bugia. L’oggettività non è frutto automatico della fotografia; è nell’intenzione e nella corrispondente azione dell’emittente e dunque è il ‘lettore’ che deve saper formulare una sua valutazione davanti a ogni messaggio, sia esso un testo orale o scritto o una fotografia. (Immagine. A. Introduzione)
4. Con la fotografia il giornalista non parla un linguaggio universale
La fotografia è una tecnica comunicativa che, oltre a segni e regole propri, usa segni e interi testi elaborati in altri codici, da altri soggetti comunicanti (Fotografia). Da questo punto di vista il fotografo, più che un autore, è un regista o un direttore di orchestra; il suo contributo originale sta nel coordinare in un nuovo progetto l’apporto di altri.Non ha dunque senso affermare che esiste un unico codice fotografico, conosciuto il quale tutti possono leggere tutte le fotografie. Se conosco il codice usato dal fotografo potrò leggere quale intervento ha fatto, ma non ho la garanzia di comprendere ciascuno degli elementi da lui utilizzati. Ad esempio, quando viene fatto il ritratto di una persona, entrano in gioco messaggi di tipo prossemico (Prossemica), messaggi legati alla gestualità (ciò che dicono il volto, gli occhi, la bocca, il trucco, le mani, la positura del corpo), messaggi espressi dall’ abbigliamento, dall’ambiente e dal suo arredamento. Il risultato finale – la fotografia – è sotto gli occhi di tutti, ma non è possibile affermare che tutti la leggano alla stessa maniera. È vero che la diffusione nel mondo della televisione e delle lingue occidentali (che si scrivono in modo equivalente e dunque organizzano lo spazio bidimensionale in modo simile) ha dato vita a una specie di esperanto grafico-visivo, ma non è vero che l’espressione di un viso napoletano sia trasparente per un giapponese o un lituano (e – ovviamente – viceversa).
Meglio affermare che la fotografia dice molte cose e, in quel che dice, è polisemica, si presta cioè amolte letture. Per completarla e per ridurne l’ambiguità molto spesso c’è bisogno dell’intervento di un testo capace di vincolare la libertà del lettore e dirigerlo sul messaggio inteso dall’emittente. Se la fotografia non dice, o non dice a tutti, il dove, il chi, il che cosa, il come, il quando, il perché, lo scopo di un determinato avvenimento, è giocoforza ricorrere ad altri testi: possono essere anche altre fotografie ma spesso il testo scritto – nelle varie lingue! – si rivela indispensabile.
Non è logico dunque contrapporre la parola scritta all’immagine sulla base della maggiore veridicità e comprensibilità dell’una rispetto all’altra. Così non ha più senso contrapporre la figura del giornalista a quella del fotogiornalista (o del giornalista che lavora alla radio, in televisione, in Internet). Oggi la stessa persona può, e probabilmente deve, sapersi esprimere con tutti questi media.
5. Problemi irrisolti
Nel mestiere del fotogiornalista ci sono altri problemi irrisolti che continuano a creare illusioni e difficoltà insieme.– L’informazione opposta allo spettacolo. Sono realtà diverse, ma non si escludono in modo radicale. L’errore è confonderle, fingendo di fare informazione là dove invece interessa soltanto catturare l’attenzione del pubblico per scopi diversi che fornire notizie.
– Il diritto/dovere di informare, contrapposto al bene del singolo e al bene comune. Ci sono dei limiti da rispettare (come nel caso della privacy), ma ci sono anche limiti che andrebbero violati, ad esempio molti dei divieti imposti da una dittatura.
– Il rischio che l’informazione diventi condanna. In alcuni casi la scelta – se scattare o non scattare una fotografia – può essere tragica (comunque si decida). Nel 1989, a Pechino, nella piazza Tien An Men, sarebbe stato un delitto non documentare al mondo la rivolta degli studenti, ma è bene ricordare che la scelta di documentare con la fotografia l’accaduto ha dato in mano alla polizia lo strumento per identificare le persone da fucilare.
– Le immagine sono efficaci, ma non da sole: è senz’altro vero che il sacrificio di molti fotografi e cameraman morti in Vietnam (come in altri conflitti), provocando con le loro immagini l’orrore della guerra e un vivo senso di ribellione nella maggioranza di cittadini, ha contribuito ad accelerare la conclusione del conflitto (la controprova la si ha osservando il modo di operare dei militari nei conflitti successivi: hanno cercato in tutti i modi di gestire a modo loro le immagini e i flussi informativi). Non sempre però le cose funzionano alla stessa maniera: è da un secolo che le immagini del sottosviluppo e della fame sono sotto gli occhi di tutti, ma gli ingiusti squilibri non si sono attenuati.
Tutte queste opposizioni sono oggetto di studio e molta letteratura è disponibile al riguardo. Si è arrivati anche alla formulazione di proposte operative concrete da parte di vari codici deontologici nella forma di autoregolazione o nella forma di veri e proprie leggi.
Foto
Video
Non ci sono video per questa voce
Bibliografia
- ALMASY Paul, Le photojournalisme. Informer en écrivant des photos, Presse et Formation, Paris 1993.
- CHAPNICK Howard, Truth needs no ally. Inside photojournalism, University of Missouri Press, Columbia (MO) 1994.
- CLAIR Jean, Henri Cartier-Bresson tra ordine e avventura, Abscondita, Milano 2008.
- CURTI D. et al., Professione fotografo, Il Castoro, Milano 2001.
- EDOM Clifton C., Photojournalism, principles and practices, W.C. Brown, Dubuque (IA) 1980.
- FADIGATI Neri, Il mestiere di vedere. Introduzione al fotogiornalismo, Plus, Pisa 2005.
- FIORENTINO Giovanni, L’occhio che uccide. La fotografia e la guerra: immaginario, torture, orrori, Meltemi, Roma 2004.
- FREUND Gisele, Fotografia e società. Riflessione critica ed esperienza pratica di un'allieva di Adorno, Einaudi, Torino 1976.
- HAGAMAN Dianne, How I learned not to be a photojournalist, University Press of Kentucky, Lexington (KY) 1996.
- KEENE Martin, Practical photojournalism. A professional guide, Focal Press, Oxford 1993.
- KOBRE Kenneth, Photojournalism. The professional approach, Focal Press, Oxford 1995.
- LEWIS Greg, Photojournalism. Content and technique, W.C. Brown, Dubuque (IA) 1991.
- LUCAS Uliano - AGLIANI Tatiana, La realtà e lo sguardo. Storia del fotogiornalismo in Italia, Einaudi, Torino 2015.
- NEWHALL Beaumont, Storia della fotografia, Einaudi, Torino 1984.
- SCIANNA Ferdinando, Etica e fotogiornalismo, Mondadori Electa, Milano 2010.
- WORLD PRESS PHOTO FOUNDATION, World press photo, Contrasto Due, Roma 2007.
Documenti
Non ci sono documenti per questa voce
Links
Non ci sono link per questa voce
Come citare questa voce
Lever Franco , Fotogiornalismo, in Franco LEVER - Pier Cesare RIVOLTELLA - Adriano ZANACCHI (edd.), La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, www.lacomunicazione.it (01/05/2025).
 Il testo è disponibile secondo la licenza CC-BY-NC-SA
Il testo è disponibile secondo la licenza CC-BY-NC-SACreative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo
553