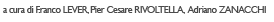Jazz
- Testo
- Bibliografia9
- Video8
- Links12
- Voci correlate
Autore: Guido Michelone
È una musica che nasce, nelle comunità afroamericane di New Orleans alla fine dell’Ottocento, dalla confluenza di altre forme sonore di origine nera o creola: il gospel e lo spiritual, canti corali delle chiese protestanti; il blues, laico e individualista di narratori itineranti; il ragtime, elegante formula d’intrattenimento per pianoforte o piccoli gruppi in sontuosi postriboli.
A loro volta gospel, spiritual, blues e ragtime assimilano influenze musicali tanto europee quanto africane: fino a metà Ottocento gli schiavi provenienti dal Congo o dalla Costa d’Oro (l’attuale Ghana), nonostante i divieti dei loro padroni, mantengono vivo il ricordo di danze e canzoni di ascendenza rituale, magica, pagana dal forte impulso ritmico e iterativo, tramandate oralmente e improvvisate in gruppo come in moltissime tradizioni folcloristiche. Finita l’epoca della schiavitù, le comunità afroamericane hanno la possibilità di far conoscenza con mondi sonori diversissimi: proprio a New Orleans si sedimentano eterogenee culture musicali che del resto corrispondono alle varie fasi della colonizzazione spagnola, francese, angloamericana. In quel crogiolo razziale è dunque possibile assimilare facilmente canti e balli d’estrazione popolare come polka, quadriglia, mazurca, flamenco, ballate anglosassoni, persino melodie napoletane, ovvero le espressioni che più o meno direttamente contribuiscono alla nascita del j. dal punto di vista del costrutto armonico e melodico. Per quanto concerne la timbrica l’ascendente è anch’esso occidentale: neri e creoli imparano a suonare soprattutto gli strumenti a fiato (e le relative marcette militari) che i soldati avevano abbandonato ai tempi della guerra civile. Trombe, clarinetti, sassofoni, tromboni svolgono il ruolo solista, mentre la funzione d’accompagnamento è affidata a una sezione ritmica composta anch’essa da strumenti europei (basso, banjo, batteria), ma impiegati in modo insolito secondo un uso che più o meno consapevolmente si rifà a saperi ancestrali.
Il diretto antecedente del j. sotto l’aspetto stilistico è comunque il rag pianistico diffuso in tutti gli Stati Uniti attraverso i tradizionali spartiti e i rulli di pianola meccanica (celebri quelli di Scott Joplin, 1868-1917), a loro volta considerati il primo mezzo di riproduzione tecnica del suono musicale.
Del j. originario di New Orleans capitanato dal leggendario Buddy Bolden (1868-1931) non resta alcuna traccia per due semplici ragioni: da un lato si tratta di musica totalmente improvvisata, talvolta suonata da strumentisti incapaci di leggere e scrivere le note sul pentagramma o comunque disinteressati a questa tipologia di elaborazione creativa; dall’altro la discriminazione razziale non consente ai musicisti neri di occupare subito gli ambìti posti dell’industria del divertimento. Il primo disco di j. arriva solo nel 1917, ma a inciderlo è l’Original Dixieland Jazz Band, un quintetto di suonatori bianchi, pallida imitazione dei veri originali. Il 1917 è d’altronde una data cruciale per il j. e per la sua diffusione su scala prima nazionale quindi planetaria, a dimostrazione, altresì, di come questa musica venga spesso fortemente condizionata dagli avvenimenti sociopolitici: in quell’anno il governo americano decide di partecipare alla prima guerra mondiale, facendo di New Orleans il maggior porto militare; per ragioni di moralità vengono evacuati gli abitanti di Storyville, il quartiere a luci rosse, zeppo di prostitute e jazzisti. L’esodo verso le grandi città del nord del Paese da Kansas City a Chicago a New York decreta anche una nuova e imprevista fortuna del j., che in breve conquista le masse urbanizzate, risultando una moda per i ricchi, un passatempo per le minoranze di colore dei ghetti.
Negli anni Venti il j. da irruente espressione folcloristica diventa quasi una forma d’arte, pur non oltrepassando gli steccati del cosiddetto intrattenimento leggero: diversi musicisti, coi loro complessini, affinano il gusto e la tecnica nel ricordo delle loro imprese a New Orleans (Jelly Roll Morton, King Oliver, Sidney Bechet), altri reclamano per sé una virtuosistica centralità di solista (Louis Armstrong, 1901-1971) o di leader (Duke Ellington, 1899-1974) nel passaggio epocale dal j. tradizionale a quello denominato classico. È una musica che conquista grosse fette di un mercato ancora nettamente distinto fra le due comunità: per i neri esistono i race records (dischi a 78 giri diffusi solo nei ghetti) o le esibizioni dal vivo in locali di terz’ordine; per i bianchi la possibilità di ascoltare gli stessi musicisti in raffinati cabaret rigorosamente vietati al pubblico di colore. Quello che allora è chiamato dixieland diventa pure un ballo (il charleston) ritenuto lascivo o sconcio dai benpensanti, anche se imperversa proprio fra la borghesia bianca o tra gli intellettuali europei (i primi in assoluto ad apprezzarne il valore intrinseco).
Il j. degli anni Venti però si diffonde soprattutto grazie al suo riutilizzo in ambito teatrale e concertistico: da un lato, infatti, i neri ottengono enorme successo con le black revues, varietà pseudoesotici come trampolino di lancio per valenti pianisti (Fats Waller, 1904-1943) o le cantanti di blues jazzistico (Bessie Smith, 1898-1937); dall’altro i bianchi si lanciano in curiosi ibridi che tentano, nei casi migliori, un felice connubio tra j. e sinfonismo (George Gershwin, 1898-1937) oppure una vena intimista e cameristica (Bix Beiderbecke, 1903-1931).
All’apice della gloria, il j. risente clamorosamente della grande depressione seguita al crac di Wall Street del 1929: calano le vendite di dischi e gli ingaggi nei locali, molti jazzisti di colore sono letteralmente costretti a cambiare mestiere o cercare fortuna in Europa. È solo dalla metà degli anni Trenta che, sull’onda dell’ottimismo del New Deal, il j. torna alla ribalta come fenomeno di massa con uno stile assai più frizzante e commerciale di tutti i precedenti: la nuova formula ribattezzata swing è dovuta ad alcune big band di colore (Count Basie, 1904-1984; Jimmy Lunceford, 1902-1947, lo stesso Ellington), ma saranno i bianchi a ottenerne i maggiori vantaggi sul piano economico, rendendo orecchiabile (e talvolta romantico) il sound jazzistico per dischi dalle vendite milionarie, ingaggi nei faraonici alberghi in località turistiche, esibizioni dal vivo alle stazioni radio più prestigiose, comparse nei film hollywoodiani per sketch musicali per promuovere le stesse canzoni.
Per circa un decennio lo swing rappresenta la musica americana per eccellenza, il corrispettivo di ciò che oggi sono il rock o il pop: la sua diffusione avviene con tutti i mezzi della comunicazione sociale allora disponibili, senza per questo diminuire la qualità artistica del prodotto medesimo. Lo swing infatti non è eseguito solo dalle orchestre di consumo (Tommy Dorsey, Harry James, Charlie Barnet), ma anche dai grandi solisti (Art Tatum, Coleman Hawkins, Lester Young), dalle cantanti (Billie Holiday ed Ella Fitzgerald) e dai piccoli insiemi, i combos, uno dei quali presenta per la prima volta una formazione mista: due bianchi, Gene Krupa e il capogruppo Benny Goodman, e due neri, Lionel Hampton e Teddy Wilson, secondo una consuetudine destinata a ulteriori emancipazioni.
Negli anni del secondo conflitto mondiale il governo degli Stati Uniti decide di sfruttare il j. a fini propagandistici, intercalando lo swing ai discorsi antinazisti nelle trasmissioni radiofoniche per l’Europa, inviando vere e proprie orchestre al seguito delle truppe e, soprattutto, fornendo a quest’ultime i cosiddetti V-disc (dischi della vittoria) incisi gratuitamente dai migliori jazzmen, che rinunciano altresì alle royalties e acconsentano alla distruzione delle matrici originarie per evitarne sfruttamenti illeciti.
Ed è dai 78 giri di Glenn Miller (1904-1944), forse la figura-simbolo del j. bellico (visto che il suo aereo viene abbattuto durante una missione) che nell’Italia liberata si comincia a far conoscenza del j. americano stupidamente vietato dal regime fascista. In Francia invece si è già sviluppata una vera e propria cultura jazzistica grazie all’ascesa di solisti quali Django Reinhardt o Stéphane Grappelli coi loro mélanges di sonorità afroamericane, zingaresche o di personalità come Boris Vian (1921-1959), poeta, cantautore, romanziere, trombettista, critico musicale, mediatore, grazie al j., fra esistenzialisti e chansonniers.
I francesi sono anche i primi ad accogliere positivamente le novità del j. moderno: a guerra conclusa a New York alcuni giovani jazzisti (Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Thelonius Monk, Max Roach, Kenny Clarke) sviluppano col bebop una ricerca sonora che simboleggia la consapevolezza della negritudine, i connotati dell’opera d’arte, il rifiuto dello sfruttamento mercantile del j. medesimo. Il j. moderno, subito osteggiato dal pubblico di massa che preferisce rivolgersi a forme più semplificate (come il rhythm and blues di Ray Charles o i crooners alla Frank Sinatra), ottiene negli anni Cinquanta un moderato trionfo attraverso la metamorfosi operata da musicisti bianchi (Stan Kenton, Gerry Mulligan, Chet Baker, Shorty Rogers, Dave Brubeck, San Getz, Lennie Tristano) con atmosfere più levigate e meno radicali, con una serie di tendenze spesso effimere, di volta in volta leggiadre (cool), consumiste (west coast), sperimentali (third stream). Nonostante la sempre maggior divulgazione sul piano mediologico ( radio, televisione, cinema), accanto a inedite tecnologie ( disco a 33 giri e stereofonia) che incidono profondamente sulle strutture musicali (i singoli brani che dai canonici tre minuti dei vecchi microsolco arrivano a durare anche mezz’ora), il j. pare ormai destinato a un uditorio sempre più frazionato ed elitario: diventa infatti il passatempo dei giovani nei campus universitari, il vessillo degli intellettuali arrabbiati (la beat generation), il punto di riferimento di poeti e romanzieri.
Salvo rare eccezioni, il j. degli anni Cinquanta e Sessanta nei gusti di massa è sostituito dal nascente rock and roll: per tali ragioni la musica afroamericana si espande fortemente sul piano qualitativo, tentando inusuali contaminazioni coi generi classici (come nel caso del Modern Jazz Quartet) o affrontando svolte controcorrente (Miles Davis, 1926-1991) o ancora riallacciandosi alla vera negritudine dell’animo musicale. Sotto quest’ultimo aspetto, dalla fine degli anni Cinquanta sino a oggi, si impone una tendenza chiamata hard bop (Sonny Rollins, Clifford Brown, Art Blakey, Horace Silver, Joe Henderson) sprizzante energia e vitalità con larghi spazi al solismo improvvisativo. Un’ulteriore valorizzazione dei momenti dinamici ed espressivi di quella che può considerarsi la linea maestra della civiltà musicale afroamericana viene simboleggiata negli anni Sessanta-Settanta, da un lato, con la perpetuazione degli stilemi del passato mediante appunto il mainstream dei grandi maestri (Ellington, Goodman (1909-1986), Gillespie (1917-1993), Davis) spesso approdati nei conservatori, nei templi della lirica, nelle sale da concerto, dall’altro estremizzando le novità dell’hard bop con atteggiamenti oltranzisti e neosperimentali: come già successo con la musica colta, anche il j. giunge quindi all’avanguardia totale con il free e la new thing (Ornette Coleman, Cecil Taylor, John Coltrane, Eric Dolphy, Archie Sheep), che sociologicamente pare segnare la presa di coscienza, a livello ideologico, del popolo nero sui problemi dei diritti civili legati alla loro identità razziale (non a caso i musicisti citati sono ammiratori di Martin Luther King, 1929-1968, o di Malcolm X, 1925-1965). Il free in America è apertamente osteggiato da pubblico e critica, mentre in Europa ottiene lusinghieri riconoscimenti presso i musicisti che ne riprendono temi e contenuti su un piano di impegno politico in sintonia ad esempio con la contestazione sessantottesca: in Italia Mario Schiano e Giorgio Gaslini, in Francia Michel Portal, in Germania Albert Mangelsdorff, ecc.
Alla fine degli anni Sessanta il j. compie un’ennesima svolta per quanto concerne la ricerca stilistica e il rapporto col pubblico, cercando di assorbire al proprio interno alcuni elementi delle sonorità pop e rock, di moda presso le masse giovanili: nasce così il rock-j. (poi ribattezzato fusion) grazie all’estro di Miles Davis e di molti suoi ex collaboratori (Chick Corea, Herbie Hancok, John McLaughlin, il Weather Report) subito invitati a festival e rassegne all’aperto di proporzioni gigantesche. Si tratta di un aspetto del costume civile che si ripercuote anche in Italia: ad esempio la rassegna Umbria Jazz diventa, a metà degli anni Settanta, un vero e proprio megaraduno, con le migliaia di giovani accampati in piazza per ascoltare i propri beniamini. Nonostante questo felice connubio fra musica j. e aggregazione giovanile, che spesso va oltre l’interesse artistico per mutarsi in pretesto di incontro generazionale, la musica afroamericana non riesce a ridiventare un fenomeno di massa come ai tempi dello swing o come sta accadendo al rock da circa un trentennio. Le vendite di dischi sono ancora basse in rapporto a quelle del pop e di conseguenza i media sono poco propensi a occuparsi seriamente di j. e dintorni: in Italia lo spazio e il tempo dedicati dalle radio libere e poi private è quasi inesistente, anche se negli Stati Uniti nascono i primi network interamente dedicati al sound afroamericano; in entrambi i Paesi la televisione offre ancor meno possibilità, con qualche rara trasmissione per lo più consistente nelle riprese di festival o concerti. Anche sui giornali l’informazione jazzistica è confinata alle pagine di spettacolo, spesso ripudiata per opposte ragione sia dalla critica rock che ritiene il j. troppo colto e raffinato, sia da quella classica che invece lo considera riduttivamente alla stregua della musica leggera. Non mancano però le riviste specializzate, per lo più mensili, propense a documentare l’attività concertistico-discografica dei musicisti, senza disdegnare saggi e approfondimenti di taglio storico e musicologico: Down Beat in Usa, Jazz Hot e Jazz Magazine in Francia, Musica Jazz in Italia (dal 1945).
Il j. contemporaneo, in quanto tale, va inteso non solo in base a stili o ragioni estetiche, ma soprattutto in un raffronto cronologico con la stretta attualità: e in tal senso la situazione della musica afroamericana degli anni Ottanta-Novanta non presenta grossi segnali di cambiamento o di evoluzione rispetto al passato recente. L’unica nota positiva è che il j., a quasi cent’anni dalla sua nascita, ottiene sempre più credibilità presso gli ambienti colti e accademici, ormai disposti a considerarlo come uno degli aspetti principali della storia musicale del sec. XX. Anche in America, dove da sempre il j., non godendo di larghi consensi ufficiali, ha per contro subito i ricatti e le imposizioni dello show business, al punto da ridurre al silenzio molti valenti artisti, è in corso una seria riabilitazione del fondamentale contributo della musica nera allo sviluppo di un’arte sonora autenticamente americana. Tutto questo avviene con numerosissime iniziative, da mostre a concerti, da dischi a musei, da film a programmi radiotelevisivi, da video ad associazioni culturali che tentano di affermare ulteriormente la dignità del j. Dal canto loro, i musicisti si prodigano in studi e riletture che, pur non aggiungendo nulla di nuovo sul piano stilistico, confermano la crescita e la vitalità del j. medesimo, che mai come in questi ultimissimi anni comprende una così eterogenea varietà di scuole, gruppi, tendenze, settori. Si va infatti dal post-free al neo-bop, passando per la word music, che vorrebbe rivelarsi come sintesi di tutti i linguaggi universali. In ogni caso, grazie all’incremento dei mezzi di comunicazione, il j. riesce anche a beneficiare di una cassa di risonanza planetaria; ormai è possibile suonare e ascoltare j. ovunque e le occasioni per conoscere i suoi maggiori esponenti sono praticamente illimitate. Pur possedendo ancora un’audience circoscritta rispetto alle folle oceaniche del rock e del pop, il j., ad esempio, in Italia pubblica ogni anno migliaia di nuovi dischi e organizza – soprattutto in estate – decine di rassegne, a cui partecipano artisti da tutto il mondo dall’Art Ensemble di Chicago al Word Saxophone Quartet, da Don Byron a Bill Frisell, da Pat Metheny a Joshua Redman, da John Zorn a Carla Bley. Il CD e la videocassetta stanno poi moltiplicando le possibilità sia di documentare l’attività creativa del j. contemporaneo sia di archiviare con notevoli migliorie tecniche i materiali del passato. Inoltre sta emergendo una inedita consapevolezza tra i jazzisti stessi: molti di loro affrontano indifferentemente i repertori afroamericani e occidentali con risultati brillantissimi in entrambi i casi. Basti pensare a Wynton Marsalis, Anthony Braxton e soprattutto Keith Jarrett: pur diversi per mentalità e generazione, essi s’impegnano nella scrittura e nell’improvvisazione, nell’eseguire la musica classica, le proprie composizioni o la rilettura del passato, prossimo o remoto, di tutto il j. afroamericano. Ed è forse su questa via della consapevolezza che il j. avrà ancora molto da dire.
A loro volta gospel, spiritual, blues e ragtime assimilano influenze musicali tanto europee quanto africane: fino a metà Ottocento gli schiavi provenienti dal Congo o dalla Costa d’Oro (l’attuale Ghana), nonostante i divieti dei loro padroni, mantengono vivo il ricordo di danze e canzoni di ascendenza rituale, magica, pagana dal forte impulso ritmico e iterativo, tramandate oralmente e improvvisate in gruppo come in moltissime tradizioni folcloristiche. Finita l’epoca della schiavitù, le comunità afroamericane hanno la possibilità di far conoscenza con mondi sonori diversissimi: proprio a New Orleans si sedimentano eterogenee culture musicali che del resto corrispondono alle varie fasi della colonizzazione spagnola, francese, angloamericana. In quel crogiolo razziale è dunque possibile assimilare facilmente canti e balli d’estrazione popolare come polka, quadriglia, mazurca, flamenco, ballate anglosassoni, persino melodie napoletane, ovvero le espressioni che più o meno direttamente contribuiscono alla nascita del j. dal punto di vista del costrutto armonico e melodico. Per quanto concerne la timbrica l’ascendente è anch’esso occidentale: neri e creoli imparano a suonare soprattutto gli strumenti a fiato (e le relative marcette militari) che i soldati avevano abbandonato ai tempi della guerra civile. Trombe, clarinetti, sassofoni, tromboni svolgono il ruolo solista, mentre la funzione d’accompagnamento è affidata a una sezione ritmica composta anch’essa da strumenti europei (basso, banjo, batteria), ma impiegati in modo insolito secondo un uso che più o meno consapevolmente si rifà a saperi ancestrali.
Il diretto antecedente del j. sotto l’aspetto stilistico è comunque il rag pianistico diffuso in tutti gli Stati Uniti attraverso i tradizionali spartiti e i rulli di pianola meccanica (celebri quelli di Scott Joplin, 1868-1917), a loro volta considerati il primo mezzo di riproduzione tecnica del suono musicale.
Del j. originario di New Orleans capitanato dal leggendario Buddy Bolden (1868-1931) non resta alcuna traccia per due semplici ragioni: da un lato si tratta di musica totalmente improvvisata, talvolta suonata da strumentisti incapaci di leggere e scrivere le note sul pentagramma o comunque disinteressati a questa tipologia di elaborazione creativa; dall’altro la discriminazione razziale non consente ai musicisti neri di occupare subito gli ambìti posti dell’industria del divertimento. Il primo disco di j. arriva solo nel 1917, ma a inciderlo è l’Original Dixieland Jazz Band, un quintetto di suonatori bianchi, pallida imitazione dei veri originali. Il 1917 è d’altronde una data cruciale per il j. e per la sua diffusione su scala prima nazionale quindi planetaria, a dimostrazione, altresì, di come questa musica venga spesso fortemente condizionata dagli avvenimenti sociopolitici: in quell’anno il governo americano decide di partecipare alla prima guerra mondiale, facendo di New Orleans il maggior porto militare; per ragioni di moralità vengono evacuati gli abitanti di Storyville, il quartiere a luci rosse, zeppo di prostitute e jazzisti. L’esodo verso le grandi città del nord del Paese da Kansas City a Chicago a New York decreta anche una nuova e imprevista fortuna del j., che in breve conquista le masse urbanizzate, risultando una moda per i ricchi, un passatempo per le minoranze di colore dei ghetti.
Negli anni Venti il j. da irruente espressione folcloristica diventa quasi una forma d’arte, pur non oltrepassando gli steccati del cosiddetto intrattenimento leggero: diversi musicisti, coi loro complessini, affinano il gusto e la tecnica nel ricordo delle loro imprese a New Orleans (Jelly Roll Morton, King Oliver, Sidney Bechet), altri reclamano per sé una virtuosistica centralità di solista (Louis Armstrong, 1901-1971) o di leader (Duke Ellington, 1899-1974) nel passaggio epocale dal j. tradizionale a quello denominato classico. È una musica che conquista grosse fette di un mercato ancora nettamente distinto fra le due comunità: per i neri esistono i race records (dischi a 78 giri diffusi solo nei ghetti) o le esibizioni dal vivo in locali di terz’ordine; per i bianchi la possibilità di ascoltare gli stessi musicisti in raffinati cabaret rigorosamente vietati al pubblico di colore. Quello che allora è chiamato dixieland diventa pure un ballo (il charleston) ritenuto lascivo o sconcio dai benpensanti, anche se imperversa proprio fra la borghesia bianca o tra gli intellettuali europei (i primi in assoluto ad apprezzarne il valore intrinseco).
Il j. degli anni Venti però si diffonde soprattutto grazie al suo riutilizzo in ambito teatrale e concertistico: da un lato, infatti, i neri ottengono enorme successo con le black revues, varietà pseudoesotici come trampolino di lancio per valenti pianisti (Fats Waller, 1904-1943) o le cantanti di blues jazzistico (Bessie Smith, 1898-1937); dall’altro i bianchi si lanciano in curiosi ibridi che tentano, nei casi migliori, un felice connubio tra j. e sinfonismo (George Gershwin, 1898-1937) oppure una vena intimista e cameristica (Bix Beiderbecke, 1903-1931).
All’apice della gloria, il j. risente clamorosamente della grande depressione seguita al crac di Wall Street del 1929: calano le vendite di dischi e gli ingaggi nei locali, molti jazzisti di colore sono letteralmente costretti a cambiare mestiere o cercare fortuna in Europa. È solo dalla metà degli anni Trenta che, sull’onda dell’ottimismo del New Deal, il j. torna alla ribalta come fenomeno di massa con uno stile assai più frizzante e commerciale di tutti i precedenti: la nuova formula ribattezzata swing è dovuta ad alcune big band di colore (Count Basie, 1904-1984; Jimmy Lunceford, 1902-1947, lo stesso Ellington), ma saranno i bianchi a ottenerne i maggiori vantaggi sul piano economico, rendendo orecchiabile (e talvolta romantico) il sound jazzistico per dischi dalle vendite milionarie, ingaggi nei faraonici alberghi in località turistiche, esibizioni dal vivo alle stazioni radio più prestigiose, comparse nei film hollywoodiani per sketch musicali per promuovere le stesse canzoni.
Per circa un decennio lo swing rappresenta la musica americana per eccellenza, il corrispettivo di ciò che oggi sono il rock o il pop: la sua diffusione avviene con tutti i mezzi della comunicazione sociale allora disponibili, senza per questo diminuire la qualità artistica del prodotto medesimo. Lo swing infatti non è eseguito solo dalle orchestre di consumo (Tommy Dorsey, Harry James, Charlie Barnet), ma anche dai grandi solisti (Art Tatum, Coleman Hawkins, Lester Young), dalle cantanti (Billie Holiday ed Ella Fitzgerald) e dai piccoli insiemi, i combos, uno dei quali presenta per la prima volta una formazione mista: due bianchi, Gene Krupa e il capogruppo Benny Goodman, e due neri, Lionel Hampton e Teddy Wilson, secondo una consuetudine destinata a ulteriori emancipazioni.
Negli anni del secondo conflitto mondiale il governo degli Stati Uniti decide di sfruttare il j. a fini propagandistici, intercalando lo swing ai discorsi antinazisti nelle trasmissioni radiofoniche per l’Europa, inviando vere e proprie orchestre al seguito delle truppe e, soprattutto, fornendo a quest’ultime i cosiddetti V-disc (dischi della vittoria) incisi gratuitamente dai migliori jazzmen, che rinunciano altresì alle royalties e acconsentano alla distruzione delle matrici originarie per evitarne sfruttamenti illeciti.
Ed è dai 78 giri di Glenn Miller (1904-1944), forse la figura-simbolo del j. bellico (visto che il suo aereo viene abbattuto durante una missione) che nell’Italia liberata si comincia a far conoscenza del j. americano stupidamente vietato dal regime fascista. In Francia invece si è già sviluppata una vera e propria cultura jazzistica grazie all’ascesa di solisti quali Django Reinhardt o Stéphane Grappelli coi loro mélanges di sonorità afroamericane, zingaresche o di personalità come Boris Vian (1921-1959), poeta, cantautore, romanziere, trombettista, critico musicale, mediatore, grazie al j., fra esistenzialisti e chansonniers.
I francesi sono anche i primi ad accogliere positivamente le novità del j. moderno: a guerra conclusa a New York alcuni giovani jazzisti (Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Thelonius Monk, Max Roach, Kenny Clarke) sviluppano col bebop una ricerca sonora che simboleggia la consapevolezza della negritudine, i connotati dell’opera d’arte, il rifiuto dello sfruttamento mercantile del j. medesimo. Il j. moderno, subito osteggiato dal pubblico di massa che preferisce rivolgersi a forme più semplificate (come il rhythm and blues di Ray Charles o i crooners alla Frank Sinatra), ottiene negli anni Cinquanta un moderato trionfo attraverso la metamorfosi operata da musicisti bianchi (Stan Kenton, Gerry Mulligan, Chet Baker, Shorty Rogers, Dave Brubeck, San Getz, Lennie Tristano) con atmosfere più levigate e meno radicali, con una serie di tendenze spesso effimere, di volta in volta leggiadre (cool), consumiste (west coast), sperimentali (third stream). Nonostante la sempre maggior divulgazione sul piano mediologico ( radio, televisione, cinema), accanto a inedite tecnologie ( disco a 33 giri e stereofonia) che incidono profondamente sulle strutture musicali (i singoli brani che dai canonici tre minuti dei vecchi microsolco arrivano a durare anche mezz’ora), il j. pare ormai destinato a un uditorio sempre più frazionato ed elitario: diventa infatti il passatempo dei giovani nei campus universitari, il vessillo degli intellettuali arrabbiati (la beat generation), il punto di riferimento di poeti e romanzieri.
Salvo rare eccezioni, il j. degli anni Cinquanta e Sessanta nei gusti di massa è sostituito dal nascente rock and roll: per tali ragioni la musica afroamericana si espande fortemente sul piano qualitativo, tentando inusuali contaminazioni coi generi classici (come nel caso del Modern Jazz Quartet) o affrontando svolte controcorrente (Miles Davis, 1926-1991) o ancora riallacciandosi alla vera negritudine dell’animo musicale. Sotto quest’ultimo aspetto, dalla fine degli anni Cinquanta sino a oggi, si impone una tendenza chiamata hard bop (Sonny Rollins, Clifford Brown, Art Blakey, Horace Silver, Joe Henderson) sprizzante energia e vitalità con larghi spazi al solismo improvvisativo. Un’ulteriore valorizzazione dei momenti dinamici ed espressivi di quella che può considerarsi la linea maestra della civiltà musicale afroamericana viene simboleggiata negli anni Sessanta-Settanta, da un lato, con la perpetuazione degli stilemi del passato mediante appunto il mainstream dei grandi maestri (Ellington, Goodman (1909-1986), Gillespie (1917-1993), Davis) spesso approdati nei conservatori, nei templi della lirica, nelle sale da concerto, dall’altro estremizzando le novità dell’hard bop con atteggiamenti oltranzisti e neosperimentali: come già successo con la musica colta, anche il j. giunge quindi all’avanguardia totale con il free e la new thing (Ornette Coleman, Cecil Taylor, John Coltrane, Eric Dolphy, Archie Sheep), che sociologicamente pare segnare la presa di coscienza, a livello ideologico, del popolo nero sui problemi dei diritti civili legati alla loro identità razziale (non a caso i musicisti citati sono ammiratori di Martin Luther King, 1929-1968, o di Malcolm X, 1925-1965). Il free in America è apertamente osteggiato da pubblico e critica, mentre in Europa ottiene lusinghieri riconoscimenti presso i musicisti che ne riprendono temi e contenuti su un piano di impegno politico in sintonia ad esempio con la contestazione sessantottesca: in Italia Mario Schiano e Giorgio Gaslini, in Francia Michel Portal, in Germania Albert Mangelsdorff, ecc.
Alla fine degli anni Sessanta il j. compie un’ennesima svolta per quanto concerne la ricerca stilistica e il rapporto col pubblico, cercando di assorbire al proprio interno alcuni elementi delle sonorità pop e rock, di moda presso le masse giovanili: nasce così il rock-j. (poi ribattezzato fusion) grazie all’estro di Miles Davis e di molti suoi ex collaboratori (Chick Corea, Herbie Hancok, John McLaughlin, il Weather Report) subito invitati a festival e rassegne all’aperto di proporzioni gigantesche. Si tratta di un aspetto del costume civile che si ripercuote anche in Italia: ad esempio la rassegna Umbria Jazz diventa, a metà degli anni Settanta, un vero e proprio megaraduno, con le migliaia di giovani accampati in piazza per ascoltare i propri beniamini. Nonostante questo felice connubio fra musica j. e aggregazione giovanile, che spesso va oltre l’interesse artistico per mutarsi in pretesto di incontro generazionale, la musica afroamericana non riesce a ridiventare un fenomeno di massa come ai tempi dello swing o come sta accadendo al rock da circa un trentennio. Le vendite di dischi sono ancora basse in rapporto a quelle del pop e di conseguenza i media sono poco propensi a occuparsi seriamente di j. e dintorni: in Italia lo spazio e il tempo dedicati dalle radio libere e poi private è quasi inesistente, anche se negli Stati Uniti nascono i primi network interamente dedicati al sound afroamericano; in entrambi i Paesi la televisione offre ancor meno possibilità, con qualche rara trasmissione per lo più consistente nelle riprese di festival o concerti. Anche sui giornali l’informazione jazzistica è confinata alle pagine di spettacolo, spesso ripudiata per opposte ragione sia dalla critica rock che ritiene il j. troppo colto e raffinato, sia da quella classica che invece lo considera riduttivamente alla stregua della musica leggera. Non mancano però le riviste specializzate, per lo più mensili, propense a documentare l’attività concertistico-discografica dei musicisti, senza disdegnare saggi e approfondimenti di taglio storico e musicologico: Down Beat in Usa, Jazz Hot e Jazz Magazine in Francia, Musica Jazz in Italia (dal 1945).
Il j. contemporaneo, in quanto tale, va inteso non solo in base a stili o ragioni estetiche, ma soprattutto in un raffronto cronologico con la stretta attualità: e in tal senso la situazione della musica afroamericana degli anni Ottanta-Novanta non presenta grossi segnali di cambiamento o di evoluzione rispetto al passato recente. L’unica nota positiva è che il j., a quasi cent’anni dalla sua nascita, ottiene sempre più credibilità presso gli ambienti colti e accademici, ormai disposti a considerarlo come uno degli aspetti principali della storia musicale del sec. XX. Anche in America, dove da sempre il j., non godendo di larghi consensi ufficiali, ha per contro subito i ricatti e le imposizioni dello show business, al punto da ridurre al silenzio molti valenti artisti, è in corso una seria riabilitazione del fondamentale contributo della musica nera allo sviluppo di un’arte sonora autenticamente americana. Tutto questo avviene con numerosissime iniziative, da mostre a concerti, da dischi a musei, da film a programmi radiotelevisivi, da video ad associazioni culturali che tentano di affermare ulteriormente la dignità del j. Dal canto loro, i musicisti si prodigano in studi e riletture che, pur non aggiungendo nulla di nuovo sul piano stilistico, confermano la crescita e la vitalità del j. medesimo, che mai come in questi ultimissimi anni comprende una così eterogenea varietà di scuole, gruppi, tendenze, settori. Si va infatti dal post-free al neo-bop, passando per la word music, che vorrebbe rivelarsi come sintesi di tutti i linguaggi universali. In ogni caso, grazie all’incremento dei mezzi di comunicazione, il j. riesce anche a beneficiare di una cassa di risonanza planetaria; ormai è possibile suonare e ascoltare j. ovunque e le occasioni per conoscere i suoi maggiori esponenti sono praticamente illimitate. Pur possedendo ancora un’audience circoscritta rispetto alle folle oceaniche del rock e del pop, il j., ad esempio, in Italia pubblica ogni anno migliaia di nuovi dischi e organizza – soprattutto in estate – decine di rassegne, a cui partecipano artisti da tutto il mondo dall’Art Ensemble di Chicago al Word Saxophone Quartet, da Don Byron a Bill Frisell, da Pat Metheny a Joshua Redman, da John Zorn a Carla Bley. Il CD e la videocassetta stanno poi moltiplicando le possibilità sia di documentare l’attività creativa del j. contemporaneo sia di archiviare con notevoli migliorie tecniche i materiali del passato. Inoltre sta emergendo una inedita consapevolezza tra i jazzisti stessi: molti di loro affrontano indifferentemente i repertori afroamericani e occidentali con risultati brillantissimi in entrambi i casi. Basti pensare a Wynton Marsalis, Anthony Braxton e soprattutto Keith Jarrett: pur diversi per mentalità e generazione, essi s’impegnano nella scrittura e nell’improvvisazione, nell’eseguire la musica classica, le proprie composizioni o la rilettura del passato, prossimo o remoto, di tutto il j. afroamericano. Ed è forse su questa via della consapevolezza che il j. avrà ancora molto da dire.
Video
Bibliografia
- The essential companion to artists and albums, Rough Trade, London 2000.
- BARAKA Amiri, Il popolo del blues, Shake, Milano 1998.
- FAYENZ Franco (ed.), Jazz, Mondadori, Milano 1997.
- FLOYD Samuel A., The power of black music, Oxford University Press, New York 1995.
- KERNFELD Barry, What to lissen for in jazz, Yale University Press, New Haven (CT) 1995.
- LIGUORI Gaetano - MICHELONE Guido, Una storia del jazz. Musica e musicisti dal 1900 al 2000, Christian Marinotti Editore, Milano 2000.
- MOUËLLIC Gilles, Le Jazz. Une ésthétique du XX siècle, Presse Universitaires de Rennes, Rennes 2000.
- POLILLO Arrigo, Jazz. La vicenda e i protagonisti della musica afroamericana, A. Mondadori, Milano 1997.
- PORTER Lewis - ULLMAN Michael, Jazz. From its origins to the present, Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ) 1993.
Documenti
Non ci sono documenti per questa voce
Links
- Collezione di album di musica jazz con possibilità di ascolto gratuito
- Sito dedicato a Ray Charles
- Sito ufficiale dedicato a Billie Holiday
- Sito ufficiale dedicato a Charlie Parker
- Sito ufficiale dedicato a Glenn Miller
- Sito ufficiale dedicato a John Coltrane
- Sito ufficiale dedicato a Miles Davis
- Sito ufficiale dedicato ai fratellii George & Ira Gershwin
- Sito ufficiale del Louis Armstrong House Museum
- Sito ufficiale dell’Umbria Jazz Festival
- Sito ufficiale della famosa rivista statunitense Down Beat dedicata al jazz
- Storia e discografia del quintetto Original Dixieland Jazz Band
Come citare questa voce
Michelone Guido , Jazz, in Franco LEVER - Pier Cesare RIVOLTELLA - Adriano ZANACCHI (edd.), La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, www.lacomunicazione.it (19/07/2025).
 Il testo è disponibile secondo la licenza CC-BY-NC-SA
Il testo è disponibile secondo la licenza CC-BY-NC-SACreative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo
707